di Ferruccio Del Bue
La sera del 20 agosto del 1946, a Campagnola Emilia (nella Bassa reggiana), zona che fu teatro di duri scontri durante la resistenza, di eliminazioni di partigiani da parte dei fascisti e vendette nell’immediato dopo liberazione (il paese del cavòn, dove sono sepolte decine di persone dalla fine dell’aprile del 1945), venne ucciso in un agguato, proprio dinnanzi all’uscio di casa, il capitano dell’esercito Ferdinando Mirotti, un giovane uomo di 34 anni.
Il padre era un fattore presso Antonio Conti Barbieri, una delle famiglie più ricche della zona, e Ferdinando era cresciuto in un ambiente cattolico, che aveva partorito un fratello sacerdote e due sorelle suore.
Ferdinando Mirotti, per mettere in chiaro le cose, era certamente un fascista, a testimoniarlo è lo stato di servizio: “Nato a Campagnola il 29 marzo 1912, geometra e impiegato. Ha prestato servizio militare in Artiglieria con il grado di sottotenente. Iscritto al Pnf dal 24 maggio 1934, iscritto alla MVSN, iscritto al sindacato pubblico impiego. Medaglia di bronzo e Croce spagnola. Volontario OMS. Dal 17 luglio 1939 è membro del direttorio del fascio di combattimento di Campagnola”.
Per di più a Mirotti, che aveva combattuto con l’esercito dalla parte di Franco, si contestava anche una spacconata, una vanteria al bar del paese, quando al suo rientro a Campagnola, nel 1939, lo avevano sentito dire: “Di rossi in Spagna ci sono rimasto soltanto io”, aveva gettato lì con una battuta, riferendosi al colore dei suoi capelli.
Ma ugualmente quel delitto a Campagnola Emilia, sin da subito, apparve ai più incomprensibile e allarmante. Incomprensibile, perché erano ormai lontani i tumultuosi giorni della liberazione, e allarmante, perché quasi un anno e mezzo dopo il cessate il fuoco, nel Reggiano, risuonava ancora il sinistro rumore dei proiettili della raganella e continuava a scorrere sangue.
Bisogna anche aggiungere, per mettere le carte in tavola già all’inizio della vicenda, che la situazione allarmante lo fu per davvero, se non addirittura per certi versi fuori controllo, come dimostrerà questa intricata trama che si dipanerà mostrando pieghe a dir poco sconvolgenti, soprattutto quando apparirà evidente che l’omicidio del militare venne deciso da alcuni esponenti del Pci, prima membri di spicco della lotta partigiana e in seguito, nel dopoguerra, anche della politica reggiana, i quali però non si fecero scrupolo a trascinare nell’azione delittuosa persino i parenti più stretti o altre persone innocenti, uno fra questi, e non fu il solo, Egidio Baraldi, che non era neppure presente alla riunione in cui venne sentenziata la fine del capitano.
Se ci fosse qualche dubbio in merito ai fatti sopra descritti, bene allora sono ancora più esplicite le parole di Gino Bellesia, bracciante e poi fruttivendolo, che nell’ottobre del 1997 scrisse prima al magistrato: “Signor procuratore della Repubblica, non voglio finire i miei giorni con sulla coscienza questa Verità. Egidio Baraldi non è il mandante dell’omicidio Mirotti. Io sapevo tutto, già il giorno dopo quella morte”. E poi aggiunse davanti alla Corte d’Assise di Perugia: “La morte del capitano fu decisa dal direttivo del Pci della sezione di Campagnola. Il sindaco di allora mi disse che il compito di organizzare tutto era stato affidato a Renato Bolondi. Fu lui il mandante dell’agguato”.
Ricordiamo anche, però, che Egidio Baraldi non ebbe bisogno di attendere il ‘Chi sa parli’ di Otello Montanari del 29 agosto 1990 per esporsi personalmente denunciando mandante ed esecutori del delitto Mirotti, essendone egli totalmente innocente, ancorché ingiustificatamente condannato.

Otello Montanari
Certamente l’omicidio di Mirotti, quando ormai si poteva almeno sperare che gli odi, il livore e le vendette alimentate da una dura e cruda guerra, che fu anche civile, potessero cominciare a sopirsi, alimentò disordine e confusione. Tanto è vero che lo stesso Volontario della Libertà, il giornale dei partigiani che vedeva fascisti quasi dappertutto, arrivò sorprendentemente a scrivere in merito all’assassinio del militare: “Un nuovo crimine è stato commesso a Campagnola, di cui è stato vittima un nostro compagno, un combattente, il capitano Ferdinando Mirotti”. E loro compagno certamente Mirotti non lo era mai stato.
Mentre in una deposizione avvenuta dopo l’assassinio, Anselmo Mirotti, fratello dell’ucciso, mise a verbale: “Quelli che comandavano a Campagnola erano il Bolondi e il Baraldi. Non si faceva discussione su quanto loro dicevano o disponevano”. Affermazione in parte vera, ma la vicenda giudiziaria dimostrò che in questo caso Egidio Baraldi non aveva disposto un bel nulla.
Tornando alla cronaca del delitto, don Wilson Pignagnoli, prete e giornalista che si occupò di molti casi del dopoguerra reggiano con ricostruzioni anche di parte, scrisse in merito alle circostanze dell’omicidio: “Sulla piazza di Campagnola si aprono, sotto i consueti portici emiliani, i negozi e i caffé, abituali luoghi di raduno, questi ultimi, in particolare dopo la cena, per gli uomini del paese”. Anche i cugini Mirotti in quella sera dal clima caldo e umido in stile agostano della Bassa, sudore e zanzare, fecero capolino nel cuore del paese per scambiare due chiacchiere con gli amici. Poi verso le 23 i due si incamminarono sulla strada facendo i passi a ritroso, per rincasare. Il primo a raggiungere la propria abitazione fu il capitano Ferdinando Mirotti, mentre il cugino Oliviero, dopo un breve saluto, si congedò per andare anch’egli a dormire. Stava li vicino. Ma non fece in tempo a inserire la chiave nella toppa della serratura che udì alcuni netti e vicinissimi colpi d’arma da fuoco e venne colto da un fremito improvviso. Fino in fondo al centro del piccolo comune della Bassa arrivò l’eco degli spari, tanto da diffondere un certo panico nell’aria. Ma primi fra tutti i botti impressionarono i familiari del capitano Mirotti, che avevano udito le detonazioni come se fossero state esplose davanti a casa loro. E in effetti fu proprio così.
La signora Giovannetti Mirotti, la madre del capitano, aprì la finestra per chiamare il nome del figlio: “Ferdinando?”. Ma questi giaceva già riverso a terra, proprio sulla soglia di casa, e accanto al suo corpo ancora caldo, una pozza di sangue, nero e grumoso. Egli, trascendendo, ebbe appena il tempo di mormorare con un ultimo soffio di vita: “Mamma, muoio”.
Il quotidiano del tempo, Reggio Democratica, e anche il Giornale dell’Emilia, tramandano oggi a noi i particolari di quell’omicidio, ma con alcune differenze dalla versione fornita da don Wilson Pignagnoli. Secondo il quotidiano reggiano: “Cessato il fuoco, durato pochi attimi (furono sparati dai 25 ai 30 colpi), il fratello del Mirotti si precipitava alla porta e si trovava di fronte il cadavere del capitano. Con la speranza di salvarlo, aiutato dal cugino, accorso egli pure al rumore degli spari, il Mirotti trasportava il corpo del fratello in casa e lo adagiava sul letto, dove poi veniva trovato dal maresciallo dei carabinieri di Novellara”.
Secondo la ricostruzione del Giornale dell’Emilia: “Mirotti era ritornato tra i familiari in licenza per un mese, e quel martedì sera, erano circa le 23.50, davanti alla porta della sua casa a Campagnola, ignoti assassini, nascosti dietro una siepe, o un albero del giardino, lo hanno freddato con una raffica di mitra sparata a 20 metri di distanza. I banditi, poi, per essere certi di averlo assassinato, dopo che era caduto a terra, sparavano una seconda raffica sul corpo ancora palpitante degli ultimi aliti di vita”.
Egidio Baraldi, nato da contadini di Cavezzo (Modena) nel 1920, partigiano comunista e vice-commissario della 77esima brigata Sap Fratelli Cervi, nel dopoguerra fu ingiustamente accusato dell’omicidio del capitano di artiglieria Ferdinando Mirotti, condannato a 23 anni di carcere, ne scontò sette. Solo nel 1998 venne riconosciuta la sua innocenza. E’ scomparso nel 2011. Nel suo libro “Il delitto Mirotti, ho pagato innocente”, rileva come la “questura di Reggio Emilia e i carabinieri di Novellara, conducendo le prime indagini, avevano redatto un verbale di ricognizione nel quale era stato annotato che i colpi sparati erano stati 36, trovati tutti in un unico mucchietto, il che li aveva fatti presumere che a premere il grilletto fosse stata una sola arma e quindi anche una sola persona.

Egidio Baraldi
Infine, Eugenio Corezzola (partigiano nelle Fiamme Verdi, e poi giornalista con il nome di Luciano Bellis), così riportò i contorni della vicenda sul giornale La Penna del 24 agosto 1946: “La sera del 20 agosto, martedì, al caffé di Campagnola, si fermò il capitano Ferdinando Mirotti, che già da 12 anni non si vedeva più in paese. Era in compagnia del cugino. Dal tempo che aveva lasciato Campagnola, Mirotti era quasi sempre stato militare in qualità di ufficiale. Aveva fatto la guerra in Spagna, con l’esercito. Era stato fatto poi prigioniero dagli americani. Rimpatriato, aveva ripreso servizio nell’esercito di liberazione con il grado di primo capitano. Ora si trovava distaccato a Mestre”.
L’articolo prosegue avanzando sospetti su due giovani in divisa cachi che furono visti subito prima del delitto, verso le 23, su una moto Gilera, cilindrata 250.
Per scatenare un omicidio, la storia della battuta lanciata al bar fatica a poter essere creduta. Bisognava avere una certa memoria e una sorta di ansia di vendetta senza tempo. Eppure anche le rivelazioni seguenti riportano a questo strano movente. Secondo Egidio Baraldi si parlò anche di “vagoni piombati pieni di italiani da inviare in Germania, ma tutte quelle cose vennero dette e poi contraddette, senza potere trovare un riscontro nei fatti”. Baraldi sostiene che Mirotti “era stato fatto prigioniero dagli alleati, essendo un ufficiale in servizio permanente effettivo, ma che non collaborò, preferendo la prigionia. Quando lo uccisero era in servizio nella zona di Mestre, ed era venuto in licenza”.
Si disse inoltre che il movente dell’omicidio del capitano dovesse essere ricercato anche nella parentela e per i contatti tenuti con il gerarca Arturo Plessi, il quale terminata la guerra riuscì a sfuggire alla vendetta dei compaesani. Egli era considerato l’intellettuale locale del fascismo, e a Campagnola era stato il segretario del fascio tra il 1941 e il 1942. In seguito aderì anche alla repubblica di Salò, rimanendo nel comune reggiano sino alla fine del marzo del 1945. Poi riparò altrove. Si disse in Veneto. Di qui, probabilmente, l’ipotesi di un contatto tra i due. Questo fatto spiegherebbe la premeditazione del delitto e quel portafogli che Renato Bolondi (scomparso nel 1995, storico sindaco del Pci di Luzzara per molti anni nel dopoguerra, prima partigiano e comandante della 77esima brigata Sap, in seguito finito carcere per l’omicidio del capitano Mirotti e poi liberato), dimenticò sul tavolo di lavoro di Egidio Baraldi all’Anpi di Campagnola e che conteneva la lettera sottratta alle poste del comune nella quale Mirotti annunciava la data del suo rientro in paese.
Il verbale del processo annotò poi che Mirotti aveva intenzione di fermarsi a Campagnola il minor tempo possibile, ed era tornato anche per parlare con Aldo Magnani (con lo pseudonimo di Rossi, fu tra i promotori della resistenza nel Reggiano e dopo l’8 settembre rappresentò il Pci nel Cln provinciale, diventandone il presidente. Finita la guerra ricoprì cariche politiche e amministrative), il quale lo doveva facilitare per aprire un’agenzia a Venezia. Mirotti era arrivato nella Bassa reggiana in corriera da Verona il giorno di lunedì 19 agosto ed era uscito solo il martedì 20 per andare dalla signora Plessi, la moglie del gerarca Arturo. E dopo cena, la sera dell’omicidio, era uscito di casa con il cugino Oliviero.
Ecco come Egidio Baraldi nelle sue memorie raccontò di avere vissuto i momenti dell’omicidio di Campagnola quel 20 agosto del 1946. In quell’istante egli si trovava al campo delle bocce, dove gli abitanti della Bassa e non solo, erano soliti trascorrere le serate estive. “Eravamo una quindicina di persone. Occupavamo tre campi da gioco. Con me tirava il Bolondi, Evandro Guaitolini e altri tre”. All’improvviso alla bocciofila irruppe il compagno Lucio Mora che ad alta voce, quasi urlando, disse: Maggi (nome di battaglia del partigiano Renato Bolondi), Walter (nome di battaglia del partigiano Egidio Baraldi), correte, che si sono sentite delle raffiche di arma automatica dietro la chiesa, in direzione Mirotti o dai Mirotti. Aggiunge Baraldi: “Udimmo tutti distintamente le frasi pronunciate da Mora e ci portammo nella direzione da lui indicata che distava 400 o 500 metri”. Già prima di arrivare a destinazione “vedemmo la casa di Mirotti illuminata. Quando entrammo, fummo introdotti nella stanza del piano superiore, dove, sul letto, giaceva il cadavere del capitano. Era la prima volta che vedevo quel volto”, spiega Baraldi: “Rimanemmo circa mezz’ora per sentire dal padre e dal cugino come erano andate le cose. Guardandomi attorno, sia al pian terreno sia nella stanza, notai la mancanza di alcune persone che erano partite dal gioco delle bocce assieme a me, una di queste era proprio Bolondi”. E su quell’assenza di Bolondi aggiunge: “In quel momento non ci feci caso. Ma in seguito, quando fummo arrestati, quel particolare mi arrovellò il cervello, ponendomi continui interrogativi”.
Alcuni mesi dopo il delitto, primi di febbraio del 1947, vennero arrestate tre persone dal gruppo investigativo che faceva capo al capitano dei carabinieri di Reggio Emilia Pasquale Vesce: Mario Lasagni, Eugenio Mora e un certo Braglia. Rimasero in prigione per sette giorni. Poi vennero scarcerati per l’inconsistenza degli indizi. Si trattava di tre comunisti di Campagnola che in sezione erano stati uditi imprecare contro gli agrari con frasi del tipo: “Bisognerebbe ammazzarli”.
Poi, d’un tratto, il capitano Pasquale Vesce si imbatté in Antenore Valla, e tutto cambiò.
Chi è costui? Niente meno che l’anello di congiunzione tra i casi di omicidio di don Umberto Pessina (altro delitto nel Reggiano con implicazioni politiche) e Ferdinando Mirotti, e delle conseguenti condanne di innocenti quali Egidio Baraldi e Germano Nicolini, ex sindaco di Correggio e storico comandante partigiano con il nome di battaglia Diavolo.
Antenore Valla fu cioè l’uomo che il capitano Vesce riuscì a manipolare, colui di cui sarà ritenuta attendibile la testimonianza, ma non le sue sconfessioni seguenti (sostenne di essere stato anche torturato). E solo negli Novanta nuove sentenze dichiararono l’inattendibilità delle sue rivelazioni e la falsità delle sue ritrattazioni.
Antenore Valla, un ex operaio della Todt, non aveva partecipato alla guerra di liberazione, anzi era ricercato per un omicidio commesso il 10 maggio del 1945 ai danni di un medico di Bagnolo in Piano, tale Pietro Gaioni e per questo era scappato in Francia sotto il falso nome di Sandro Tontolini, per poi rimpatriare clandestinamente nel 1946.
Valla viene definito sia da Baraldi sia da Vesce: uno sprovveduto, un ingenuo, una persona dotata di poca intelligenza. Egli stesso era stato indicato quale esecutore del delitto Mirotti assieme a Luigi Megliorardi (i due avrebbero avuto le armi da Evandro Guaitolini, che abitava nei pressi del cimitero, e le aveva raccolte sotto un cumulo di fieno).
I cronisti de La Penna, che avevano da subito avviato una loro inchiesta sul delitto, per pugno di Eugenio Corezzola, raccontarono che già il 24 agosto del 1946 erano in grado di ricostruire l’esatta organizzazione dell’omicidio, fino a “segnare sulla carta il tragitto compiuto da due uomini, che avevano ricevuto l’ordine di sopprimere il capitano Mirotti. La sera stessa – dicono – scrivemmo quattro nomi: Valla, Guaitolini, Megliorardi, Bolondi”. Ma in modo quasi inspiegabile da agosto a dicembre del 1946 non si mosse più nulla. Così, quando Vesce arrivò, a metà dicembre, i nomi erano già stati fatti. Da qui il colloquio tra Valla e l’ufficiale Vesce dal quale uscì il nome di Baraldi e prese il via il caso.

Nel verbale Valla rivelò: “Io assieme a Meglioraldi (Luigi Meglioraldi, partigiano della 77esima Sap di Campagnola) abbiamo ucciso Mirotti. E Meglioraldi dice che a lui hanno dato l’ordine Bolondi e Baraldi”.
Antenore Valla aveva detto la sua verità e subito erano scattate le manette per i presunti colpevoli: Renato Bolondi, Egidio Baraldi, quali mandanti, Luigi Meglioraldi e lo stesso Valla, quali esecutori. Evandro Guaitolini nel ruolo di correo, in quanto avrebbe fornito le armi per il delitto.
Ma perché Valla accusò se stesso e anche chi non c’entrava nulla niente meno che di un delitto? Di Antenore Valla e del suo carattere abbiamo già riferito ciò che fu detto e scritto. E così delle sue peripezie giudiziarie relative a un omicidio, della sua fuga in Francia, e poi del ritorno da clandestino nella sua Campagnola poco tempo prima dell’assassinio di Mirotti. Era nato a Campagnola nel 1912 da genitori braccianti, un mestiere che aveva svolto anche lui. Dopo la liberazione, e prima dell’omicidio del dottor Pietro Gaioni, aveva fatto l’autista in presidio della polizia partigiana nella frazione di Villarotta di Luzzara. Disse quel che qualcuno voleva sentirsi dire? Venne indotto a ciò con metodi non ortodossi? E’ quello che lo stesso Valla affermò più volte quando volle ritrattare tutto, sia relativamente al delitto don Pessina sia per quello di Ferdinando Mirotti. Interrogato il 26 aprile del 1947 nel carcere di Parma dal giudice Condorelli, Antenore Valla ritrattò la sua ammissione di colpa, dicendo testualmente: “Ritratto la confessione resa sia al capitano Vesce sia alla signoria vostra. Fui indotto a dichiararmi responsabile dell’omicidio di Mirotti perché il capitano Vesce mi condusse in una caserma di Bologna dove fui picchiato, sbattuto contro il muro, preso per i capelli per circa due ore da due suoi agenti che erano con lui a Novellara, fino a quando non mi decisi a confessare nel modo da loro voluto”. E aggiunge: “Davanti alla signoria vostra confermai la mia precedente confessione, perché temevo che se avessi fatto il contrario, il capitano Vesce mi avrebbe prelevato dal carcere, ricondotto a Bologna per sottopormi alle medesime torture… Feci il nome di Megliorardi perché mi fu indicato e suggerito dal capitano Vesce”.
Dinnanzi alla Corte di Assise di Perugia, era il 28 novembre del 1949, Valla dichiarò in modo ancora più esplicito: “Non so niente. Sono innocente. Sono stato costretto a fare la confessione perché maltrattato dai carabinieri”.
Dal canto suo, il capitano Pasquale Vesce, che, anche grazie alle investigazioni sui casi del reggiano era infine stato promosso al grado di generale, ben 45 anni dopo rispose così in un’intervista pubblicata nel 1990 da Ricerche Storiche: “Tra i responsabili della morte dell’ufficiale (si intende Mirotti), identificai un certo Antenore Valla, che fermai e custodii nella caserma di Novellara. Si esprimeva con tono di voce basso e manifestava un carattere docile e remissivo”. Continua il militare: “La stagione in quei primi giorni di marzo era piuttosto rigida, la caserma, di vecchia costruzione, umida e fredda, con camere di sicurezza buie e affatto ospitali”. Così, “provai una certa compassione per il Valla e a dispetto del nostro regolamento non lo misi in cella e disposi che fosse trattato con un occhio di riguardo. Infatti dormiva nella cucina al caldo. Lo facevo intrattenere con la fidanzata che gli portava da mangiare un vitto senza dubbio migliore di quello che gli poteva passare la caserma. Questo trattamento di particolare favore aveva anche l’obiettivo di accattivarne la fiducia”. Valla viene in seguito trasferito a Bologna, e sostiene il carabiniere Vesce: “Tolto dagli agi goduti a Novellara, lontano dalla fidanzata, privato del vitto abbondante e familiare a cui era abituato, e in più isolato in un fredda camera di sicurezza, mi fece avvertire che intendeva parlarmi”.
Negando dunque qualsiasi forma di tortura fisica e facendo menzione solo a una pressione di ordine psicologico, Vesce di fatto contraddice apertamente (come del resto la prima sentenza della Corte d’Assise di Perugia del febbraio del 1949) ciò che Valla aveva denunciato e che poi al contrario la sentenza del processo di revisione certificherà.
Tornando all’omicidio e alle indagini che ne seguirono, Luigi Megliorardi, uno dei due esecutori dell’omicidio, secondo la prima testimonianza di Antenore Valla, era nato a Campagnola nel 1920 e aveva esercitato li per anni la sua attività di meccanico. Anche Megliorardi aveva partecipato alla guerra di liberazione nelle fila della 77esima brigata Sap Fratelli Manfredi. Non era, contrariamente a Baraldi e Bolondi, un partigiano prestato alla politica, così, finita la guerra, ritornò al suo lavoro.
L’altro accusato ingiustamente, invece, Evandro Guaitolini, nato a Campagnola nel 1912, era fratello di Elievore, che verrà chiamato in causa come esecutore materiale dell’omicidio dallo stesso Egidio Baraldi, dopo la confessione di Bolondi in carcere. Purtroppo anche l’incolpevole Evandro conoscerà la condanna. Infine, Egidio Baraldi imparò del suo stato di imputato ai primi di marzo del 1947, quando venne invitato a recarsi a Novellara da un carabiniere e poi interrogato e arrestato dal capitano Pasquale Vesce.
Egli però non racconta fatti relativi a maltrattamenti o torture. Chi invece mise nero su bianco la sua odissea, in un linguaggio rudimentale ma efficace, fu Luigi Meglioraldi. Disse di essere stato preso a pugni, calci e ceffoni dai carabinieri fino a quando non si stancarono di “menarlo”. E che poi, quando il capitano (Pasquale Vesce), seppe dai suoi uomini che non aveva parlato, intimò: “Ci penso io. Fatelo spogliare che lo lego per i testicoli e vedrete che parlerà”. Luigi Megliorardi non firmò però la confessione che gli era stata sottoposta dagli investigatori, i quali evidentemente si impegnarono nel tentativo di difendere fino in fondo e a ogni costo le ammissioni estorte ad Antenore Valla.
Fatto sta che già in carcere e in attesa di processo, era il 1948, Egidio Baraldi si sentì rassicurare da Renato Bolondi, suo compagno di cella: “Ti dico e ti ripeto che noi siamo tutti innocenti e ci dovranno ben presto rilasciare”. Lo stesso Bolondi aggiunse anche un’ulteriore confessione: “Voi dovete stare tranquilli. Gli esecutori non sono quelli indicati, io lo so di certo”. E alla replica di Baraldi, come egli stesso ebbe a scrivere: “Sarà anche vero che hanno sbagliato con gli esecutori, ma hanno individuato il mandante”, Bolondi gli rispose “in modo affermativo”. Poco dopo si compì la confessione sul movente, spiegata ancora da Baraldi. Si torna qui a quel portafoglio dimenticato sulla scrivania nella sezione dell’Anpi, che Bolondi ritirò in ballo: “Quel portafoglio era arrivato alla posta di Campagnola, era indirizzato alla famiglia di Arturo Plessi, gli addetti alla posta me lo consegnarono. Dentro c’era una lettera che spiegava che il tal giorno sarebbe venuto a casa Mirotti, che si sarebbe recato dalla famiglia Plessi e che dalla lettura di quella lettera avrebbe capito tutto”.
Sarebbe dunque bastato questo per dare i fatali ordini a “Elievore Guaitolini e a Losi (detto il Moro) di tendere l’imboscata alla vittima”.
Baraldi (dice nel suo libro) conosceva dunque dalle parole di Bolondi tutta la verità, con l’unica eccezione sull’identità del terzo uomo, che poi lo stesso Bolondi ammise essere stato niente di meno che suo fratello, Ermes. Quelle clamorose notizie non furono un segreto, tanto è vero che Baraldi le rivelò al segretario della federazione del Pci di Reggio Emilia, Arrigo Nizzoli. Mentre da parte sua Renato Bolondi disse di avere informato dell’accaduto il dirigente provinciale comunista Scanio Fontanesi. L’impressione che Baraldi mise in calce nelle sue memorie è che quei fatti fossero già a conoscenza di Nizzoli, che egli stesso ebbe poi modo di incontrare in carcere. E in quella cella (mentre era in corso il processo di un altro omicidio del dopoguerra, quello di don Umberto Pessina), Egidio Baraldi, in presenza di Evandro Guaitolini, Ello Ferretti e Renato Bolondi, affermò: “Gli avvocati mi hanno detto che quelli che hanno commesso il delitto di Mirotti sono dei delinquenti che hanno fatto un grande male al partito e alla resistenza e che dovrebbero avere il coraggio civile e morale di assumersi le loro responsabilità per fare uscire tutti gli innocenti”. Poi, rivolgendosi a Bolondi: “Tu sai di cosa si tratta, tu sai di essere il mandante per averlo ammesso anche di fronte a Nizzoli, non ti sembra sia giunto il momento di assumerti le tue responsabilità?”. Allora, concluse Baraldi, fu in “quel momento che Bolondi si prese la testa fra le mani, piangeva e singhiozzava, e disse queste cose: ‘Hai ragione. E’ ora che io prenda la decisione. Rimane però un grave problema, oltre ai due esecutori di cui ti ho detto, ce n’è un terzo. Questi è mio fratello, Ermes. Se i miei genitori sapessero che ho fatto fare un fatto così grave a mio fratello, che non ha nemmeno vent’anni, non mi riconoscerebbero nemmeno come loro figlio”.

Arrigo Nizzoli durante un comizio
Bolondi disse di essere pentito. Scrisse anche una lettera (racconta Baraldi), “gli chiedo di leggerla ad alta voce”. Era indirizzata a Elievore Guaitolini (nella tragedia colpevoli-innocenti non vi era solo il dramma di dover denunciare il proprio fratello, ma anche quello di un altro innocente, Evandro Guaitolini, accusato ingiustamente di avere fornito le armi, mentre suo fratello Elievore, era colui che materialmente aveva sparato al capitano Ferdinando Mirotti).
Nella lettera Bolondi invitò Guaitolini: “Caro Elievore – c’è scritto – vai a disseppellire il mitra, portalo ai carabinieri di Novellara, racconta tutta la verità. Se riuscirai a lasciare fuori da questa storia mio fratello Ermes, ti sarò grato per tutta la vita”. Aggiunge Baraldi: “Quando sento i nomi dei veri esecutori, chiedo a Ello Ferretti, che ha una matita in mano, di scrivermeli su un pezzo di carta, per ricordarli”.
Ma annotò amaro Baraldi: “Non si trovò nessuno disposto a mettere in pratica questo piano, tranne i miei fratelli”. Così quel mitra Breda resterà sepolto da qualche parte e dello scritto di Bolondi invece si sono perse le tracce. C’è il biglietto scritto da Ello Ferretti, è agli atti processuali. Ma Ferretti non confermò: “Stavo facendo le parole crociate, Baraldi mi disse di appuntare un nome. Non so altro”. E infatti, davanti alla Corte d’Assise, in quello che la Gazzetta dell’Emilia definì “un drammatico confronto”, Ferretti disse subito: “Non sono disposto a servire questa giustizia che mi ha colpito innocente”.
Si fa qualche indagine, ma non approda a nulla. Il fratello di Renato Bolondi, Ermes, viene arrestato per qualche giorno. Gli altri esecutori non vengono trovati. Il partito li aveva avvertiti, erano scappati. Tutti saranno assolti per insufficienza di prove.
I responsabili del delitto Mirotti, parliamo di Elievore Guaitolini, Amos Losi ed Ermes Bolondi, furono fatti espatriare su iniziativa del partito. Contrariamente a quanto fatto dai due fuggiaschi del delitto di don Pessina, questi però non lasciarono nessuna confessione scritta che potesse scagionare gli innocenti. E’ dunque chiaro che il partito, anche quello non coinvolto direttamente negli atti di sangue, anche quella parte che quegli stessi atti condannava e riteneva anzi deleteri per la sua azione e credibilità, si sentisse prioritariamente impegnato a difendere l’interesse del Pci, prima ancora che quello della verità. E questa prassi non si riferisce solo al dopoguerra e a una situazione di fragili e contraddittori equilibri democratici, ma si protrarrà a lungo, almeno fino alla crisi definitiva del comunismo. Sopravviverà persino durante la fase del terrorismo, anche durante i governi di solidarietà democratica (1976-1979), con la giustificazione che la linea della fermezza contro le Bierre non potesse essere mischiata con la rivisitazione di episodi che generassero equivoci con la natura del Pci.
“Io ho avuto la netta sensazione – disse anni dopo la vicenda Egidio Baraldi – che una parte del partito dicesse a me di denunciare Bolondi, cosa che poi ho fatto, e l’altra parte chiedesse invece a Bolondi di tacere, che tanto non avevano le prove. Dopo un colloquio con il suo avvocato, Bolondi non disse più nulla. In compenso però uscivano dal carcere i suoi “messaggi”: io ero un traditore, un venduto al nemico. Fu in quei tempi che il negozio (da parrucchiera) di mia moglie restava vuoto di clienti”.
Su tutto, dunque, la volontà del grande partito e le sue ragioni di non sottomettersi al culto della verità, perché, come si dirà più avanti da parte di frange dell’extra-sinistra: “I compagni non si possono denunciare”.
Il processo per l’omicidio del capitano Ferdinando Mirotti si svolse a Perugia dinnanzi alla Corte di Assise a partire dai primi giorni del 1951. La sentenza si ebbe il 6 aprile, essa fu essenzialmente fondata sulla credibilità della confessione estorta ad Antenore Valla, così andarono condannati in primo grado Egidio Baraldi e Renato Bolondi alla pena di 22 anni, quali mandanti dell’omicidio, Antenore Valla, Luigi Megliorardi ed Evandro Guaitolini a 21 anni, quali esecutori. Su tutti le aggravanti per “aver concorso nel delitto in numero di cinque, e per Bolondi e Baraldi anche per avere promosso, organizzato e diretto l’attività criminosa degli altri”.
Poi fu volta della sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze, la quale attenuò le condanne escludendo la premeditazione e dichiarò la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. La pena fu così ridotta: “Antenore Valla 14 anni, Megliorardi, Guaitolini, Baraldi e Bolondi ad anni 16 ciascuno, di cui condonati anni 5 e 8 mesi per Valla, anni 6 e 4 mesi ciascuno per Meglioraldi e Baraldi”.
La Corte di Cassazione ridusse ancora una volta la pena a 8 anni e 9 mesi, di cui altri 3 condonati con provvedimento del 24 dicembre 1953. Nello stesso mese dello stesso anno, tutti i protagonisti di questo dramma padano poterono riprendersi la libertà.
Egidio Baraldi solo quarant’anni dopo, in ben altro contesto storico e politico, c’era già stato il ‘Chi sa parli’ di Otello Montanari nel 1990, vide riconosciuta la propria totale innocenza nel marzo del 1998 con la sentenza di revisione della Corte di Appello di Perugia.
(Un particolare ringraziamento per la preziosa collaborazione va all’amico e collega Glauco Bertani)

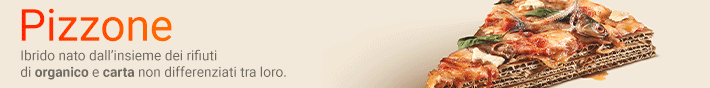





Caro Del Bue: superare la Sua cultura su tali vicende risulta impossibile. Dovetti scrivere pure io sull’ ANPI Reggiano, di tale vicenda, facendo il segretario di mio padre, Poli Bruno, che in pensione, da ex partigiano, oltre ad onorare la memoria dei partigiani caduti un zona, mi faceva battere alcuni articoli di diverse vicende del periodo della seconda guerra mondiale. Nome di battaglia Tarzan, medaglia al valore militare, etc.etc. Ma non avrei mai pensato di dover ritornare su queste vecchie situazioni perche’ scalpita la campagna elettorale alle europee. Io riconosco che le contrapposizioni non furono nette, ma ormai tali vicende non devono incantare gli elettori. Anche se la Guerra e’ un termine ” vomitevole”, ma ancora continua purtroppo ad esistere, i modelli di sviluppo economico in Europa hanno fatto dimenticare vicende di decenni fa. Io applaudo il Suo impegno e soprattutto la ricerca, ma esiste un domani che possa consentire di fare dimenticare tali vicende. Magari si soffermi,se puo’ , sul crollo del Ponte di Genova, faccia le Sue brave ricerche, ci illumini. Tanto so gia’ a. Mio avviso che non lo fara’. A parte questo, la ringrazio per. questo esauriente racconto dei fatti, cosi’ mi e’ tornato alla mente mio padre, che si prese pure una pallottola,di rimbalzo, a una gamba. E ne avrebbe pure fatto meno di quella guerra. Ma ora e’ il momento di un ” nuovo piatto”, non della solita minestra riscaldata. Grazie per l’ attenzione,.Fausto Poli.