di Ferruccio Del Bue
(Se n’è andato sabato sera a 101 anni. Germano Nicolini, nato a Correggio, classe 1919, ex comandante partigiano decorato col nome di Diavolo, già sindaco del suo paese e segretario dell’Anpi, considerato un capo e un combattente giusto, da amici e avversari politici, più che per le sue gesta militari o di amministratore, è entrato nella memoria collettiva e sarà ricordato come la vittima di una persecuzione giudiziaria durata per quasi mezzosecolo. Il suo nome resterà sempre legato al caso dell’omicidio di don Umberto Pessina, prete nella campagna di San Marticolo Piccolo, morto sparato il 18 giugno 1946, episodio sanguinoso di cui qui sotto ripercorriamo la vicenda).
Il Diavolo in Paradiso. Messa giù così può anche apparire un’immagine blasfema. Meglio spiegare subito l’origine di quel nome di battaglia che generò tante illazioni e segnò gran parte delle sfortune del comandante partigiano: “All’inizio della lotta clandestina (era l’ottobre 1943) il mio nome di cospirazione era Demos, che cambiai nel luglio 1944 in Giorgio, perché individuato dalla polizia nazifascista. Ma alla fine di dicembre dello stesso anno mi accadde un episodio tanto drammatico, quanto miracoloso: mentre in bicicletta percorrevo una strada di campagna, che essendo in zona partigiana giudicavo fosse sicura, una pattuglia tedesca sbucò da dietro un arigine intimando l’alt a una donna, a una ottantina di metri davanti a me, anche lei in bicicletta. D’un balzo mi gettai nel fosso, correndo a rompicollo verso un filare di alberi in cui mi infilai zigzagando, con i tedeschi che mi inseguivano e sparavano all’impazzata. Mi facevano scudo gli alberi. Credo però non fosse la mia ora, ed eccomi involato. Due sorelle che da una casa vicina seguirono la drammatica scena, esternarono il loro stupore con una frase: “L’è un Diével” (è un Diavolo)”. Da quel momento sarà il mio nome di battaglia”.

A raccontare l’episodio è Germano Nicolini, comandante partigiano Diavolo, decorato per meriti in battaglia, cattolico e comunista anomalo, apprezzato anche dagli avversari politici, democristiani e gradito perfino ai monarchici, ex sindaco di Correggio nel primo dopoguerra, poi rimosso, incarcerato e dimenticato, solo 50 anni dopo ritornato alla vita civile quale presidente della bocciofila Tre Pecche. Lì, a sudar partite mirando al boccino, su quegli stessi polverosi campi dai quali una notte era stato strappato, e dove tutto aveva avuto inizio.
E’ stata una lunga vita quella di Germano Nicolini. La sua è la storia paradossale di un combattente per la libertà privato ingiustamente della propria una volta conquistata la Liberazione. I dolori e le sofferenze della guerra per il partigiano Diavolo non furono mitigati dall’avvio della nuova Italia repubblicana. Per il primo cittadino di Correggio, trascinato nella polvere con accuse infamanti, non ci fu da godere la gioia per una rinata democrazia, e neppure i nuovi agi portati dal miracolo economico e dalla successiva espansione industriale. Mentre tutto nella società si muoveva e mutava, al contrario l’orologio del Diavolo si era fermato al primo dopoguerra. La sua vita era rimasta incantata lì, mentre il suo corpo e il suo spirito si consumavano nell’antro di una cella.

Per dare un’idea della vicenda giudiziaria di Germano Nicolini, che per sempre resterà legata indissolubilmente all’assassinio di don Umberto Pessina, il parroco di San Martino Piccolo di Correggio ucciso a rivolverate in una notte sudata di caldo e zanzare del 18 giugno del 1946, basti ricordare che dal giorno dell’arresto del comandante partigiano e dell’accusa che gli fu mossa (prima di essere l’esecutore e poi il mandante), al giorno dell’assoluzione con formula piena, per non avere commesso il fatto, dovette attendere quasi mezzo secolo. A essere precisi 47 anni.
Quel Diavolo da Correggio, accusato per il delitto del togato don Pessina, fu infatti arrestato il 13 marzo del 1947, e rimase in carcere fino alla fine del 1956, inizio del 1957. Mentre venne definitivamente assolto da ogni accusa solo nel giugno del 1994.
Insomma, si può dire che ci volle un Diavolo per saziare l’arsura di avvelenata giustizia della chiesa impegnata a piangere 10 preti assassinati, divenuti undici, contando l’omicidio proprio di don Umberto Pessina, unico però a cadere vittima di una ronda armata di comunisti reggiani.
Prima di lui, infatti, tre parroci vennero ammazzati per rappresaglia dai tedeschi in periodo di occupazione, cinque dai partigiani, tra l’armistizio e la liberazione, uno nel corso dell’insurrezione.
Per un guerriero di Dio, che vestì i panni di un vescovo della diocesi di Reggio Emilia, il monsignore vicentino Beniamino Socche, erano indubbiamente troppi: “Il mio atteggiamento – scrive il capo della chiesa reggiana nel suo diario – è stato quello di un incosciente che però si fida della Madonna e che sapeva di potere ottenere un miracolo per salvare la libertà”.
Ma questo miracolo, dopo l’omicidio di don Pessina, si trasformò nella persecuzione di un innocente, Nicolini appunto.
A tre mesi dall’uccisione del prete della Bassa le indagini dei carabinieri brancolarono nel buio pesto. E fu per questo motivo che a Reggio Emilia venne inviato il capitano Pasquale Vesce, originario di Messina, vissuto in Libia, accademia militare di Modena, mobilitato nel 1940 sul fronte dei Balcani con la Divisione Alpina Taurinense: uomo brusco, tenace e sicuro di sé. Lo spedì in provincia il colonnello della Legione di Bologna, dopo avergli assegnato quest’ordine: “Senti Vesce, ieri sono stato in visita a Reggio Emilia e il vescovo Socche mi ha fatto rimostranze perché i carabinieri non riescono o non vogliono fare luce sull’omicidio di don Pessina, sebbene egli da tempo li abbia messi sulla strada. Vai tu a Reggio e riprendi le indagini dal punto dove si sono fermate. Per prima cosa vai dal vescovo e fatti dire tutto quello che sa”.
Pasquale Vesce, fedele all’ordine del colonnello, si recò dal monsignore e a corredo dell’incontro, commentò: “Il vescovo, poverino, mi ha detto tutto, ma quel tutto non serve proprio a niente”.
Ma una cosa monsignor Socche, durante il Corpus Domini caduto nell’imminenza dell’omicidio, la disse chiara, facendone un manifesto della sua missione: “Farò noto a tutti i vescovi del mondo il regime di terrore che il comunismo ha creato in Italia”.
Erano queste le parole, i propositi, di un capo della chiesa reggiana poco propenso alla mitezza d’animo e semmai più incline alla pugna in campo aperto. Fatto sta che alla fine quella crociata ottenne un risultato: nessun uomo di Dio fu più ammazzato nel Reggiano. Ma ci fu anche un prezzo da pagare, la condanna di 3 innocenti.
La travagliata vicenda di Germano Nicolini iniziò a pochi giorni dallo scoccare dell’estate del 1946, il 18 di giugno. Quella sera don Umberto Pessina aveva scelto di cenare fuori casa. Fece ritorno in canonica verso le 22 e ad attenderlo, fatto inconsueto, trovò due tizi: Antonio Onfiani e Alvaro Righi (fratello di Ero Righi, il quale in seguito confessò di avere avuto un ruolo nel fatto di sangue).
I 2 intrattennero in chiacchiere il religioso per qualche momento. Poi, da sopra, la perpetua avvertì il priore che 2 chierici erano passati in chiesa per salutarlo, sarebbero partiti il giorno successivo per il Modenese.

Nonostante l’ora tarda, don Pessina uscì di nuovo di casa, questa volta in direzione dell’abitazione dei ragazzi, che dista qualche centinaio di metri dalla chiesa. Ma fatti pochi passi in quella direzione, rasentando il caseggiato per avere un po’ di luce che squarciasse l’oscurità che avvolgeva la campagna, il parroco venne improvvisamente aggredito e fulmineamente centrato da un colpo d’arma da fuoco al quale ne seguì in rapida successione un secondo che però non andò a segno.
La perpetua scossa e colta di soprassalto dai quei sinistri rumori, sentì tre invocazioni provenire da basso, una dietro l’altra: “Oh Dio… Oh Dio… Oh Dio…”. Aprì la porta e si ritrovò dinnanzi don Pessina, caracollante. Il prete, impallidito e sudato, senza più forze e col fiato troncato, si lasciò cadere, scivolando piano, fino a sciogliersi al suolo. E tra brividi e tremori spirò fra le braccia ossute della donna: “A mòr (muoio)”.
Le indagini della questura da subito furono indirizzate alla verifica di alcuni moventi.
Il primo fra questi esplorò presunti rapporti di un’amicizia stretta, intima diciamo pure, tra l’assassinato don Umberto Pessina e una signora del posto. Si imbastì su questa chiacchiera un cinguettio, un cicaleggio in tinte nero-rosa che venne strombazzato dalle cronache locali, e che, volando di bar in bocciofila, saltò, di bocca in bocca, facendo in breve il periplo del paese.
La seconda ipotesi riguardò invece un traffico di cavalli abbandonati dai tedeschi in fuga dopo la rottura del fronte e che sarrebero stati venduti sul mercato nero procurando presunti arricchimenti personali.
La terza indagine, infine, prese spunto dalla vicenda, alla quale si era interessato anche don Pessina, di alcune mondariso che erano state dirottate a incurvar la schiena tra i campi piemontesi, ma poi non assunte, perché ritenute delle sobillatrici. Il caso scaldò gli animi e finì sul tavolo della locale Camera del lavoro, tanto che gli inquirenti ipotizzarono che l’ammazzata potesse essere ricondotta a una vendetta consumata ai danni del religioso.
Furono queste le piste sulle quali lavorò il comandante dei carabinieri Pasquale Vesce. Ma ben presto gli accertamenti compiuti dall’ufficiale militare e dai suoi uomini nella Benemerita si rivelarono infruttuosi, percorsi speculativi dai contorni fumosi. L’unica bussola a guidare il cammino degli inquirenti sull’impervio tratturo che conduce alla verità restò scolpita nell’aria. Quella frase sibillina e ammaliatrice di una donna correggese, tale Ida Lazzaretti, conosciuta dai concittadini con il soprannome di Bugia. La confidenza era stata svelata come una rivelazione al vescovo di Reggio Emilia, Beniamo Socche, al quale la Bugia in persona raccontò di avere incontrato Nicolini nella sede dell’Anpi di Correggio (il Diavolo ne fu il segretario, per cui era facile trovarlo lì). E in quell’occasione lo sentì affermare: “E’ ora di farla finita con questi preti. E specialmente con uno. Anzi, con quello lì”.
L’obiettivo di investigatori e parte del clero reggiano era ormai chiaro, crocifiggere a tutti costi quel Diavolo di un mangiapreti. Poco importa se Germano Nicolini la sera del delitto di don Pessina fosse alla bocciofila Tre Pecche impegnato su un campo di bocce in una sfida col campanaro del paese e il vicesindaco. Se non poteva essere l’assassino, allora, poco male, era certamente il mandante del delitto. Questa era l’unica tesi possibile, da dimostare in qualsiasi teorema, anche in assenza di valide coordinate. Tanto le prove se non ci sono si fanno.
Ed ecco appunto che nel fitto del mistero irruppe sulla scena un personaggio prezioso alla manipolazione delle indagini, un certo Antenore Valla (implicato in un altro delitto clamoroso e mediatico del dopoguerra reggiano, quello del capitano dell’esercito da Campagnola Emilia, Ferdinando Mirotti, tornato dalla guerra e freddato sul cancello di casa). Ebbene, di Valla fu il pregio e l’utilità di raccontare agli investigatori esattamente quello che questi volevano sentirsi dire, peccato solo che poco tempo dopo si scoprì che all’epoca dei fatti il super testimone, pescato come un jolly dall’Arma, nei giorni dell’omicidio di don Pessina, non solo non si trovasse nella Bassa reggiana, dove si consumò l’assassinio, ma neppure in Italia. Vero come fu vero che se ne stava in ozio in un carcere francese, a Grenoble, rinchiuso sotto il falso nome di Sandro Tontolini.
Costui, il Valla, appunto, non era stato un combattente per la libertà, ma aveva fatto l’autista per la polizia partigiana. E su di lui pendeva un mandato per il prelevamento e l’omicidio di un medico di Bagnolo in Piano, tale dottor Pietro Gaioni.
Il Valla raccontò agli investigatori che per sfuggire alla cattura, su invito del comandante partigiano Renato Bolondi (nome di battaglia Maggi, prima commissario e poi comandante della 77esima Sap, la brigata partigiana che operava nella Bassa reggiana), si nascose a Fosdondo di Correggio. E aggiunse che la sera in cui fu assassinato don Pessina, da qualche tempo si trovava a casa di un certo Antonio Prodi, detto Negus, soprannome che gli derivava dal colorito scuro che aveva la sua faccia. E fu proprio il Negus, come rivelò il Valla al capitano Vesce, al termine di una serata, a confessargli: “Per ordine del Niculeìn abbiamo ucciso il parroco di San Martino Piccolo ed Curèš”.
Eccola qui la testimonianza chiave. E il Diavolo è inchiodato alla croce.
Annota il capitano Vesce: “Dopo una settimana dalla deposizione di Valla, fermo questo Negus-Prodi, il quale, poveretto, era uno sprovveduto”. Sta di fatto che Prodi, dopo numerosi interrogatori firmò almeno 5 verbali che erano uno il contrario dell’altro. Dall’ultimo emerse questa ricostruzione. Il Negus confessò che il 16 giugno andò all’Anpi di Correggio. Qui incontrò Germano Nicolini, Diavolo. E fu lui a dirgli: “Sai che il prete di San Martino è contro i comunisti e i partigiani? Bisognerebbe farlo fuori”. Così sarebbe nata l’idea di ammazzare il prete.
Due giorni dopo, era il 18 giugno, Antonio Prodi sarebbe ritornato, questa volta assieme a Ello Ferretti, all’Associazione partigiani, dove li attendeva di nuovo Nicolini. I tre inforcando le biciclette sarebbero partiti di lì per un raid con lo scopo di punire o fare fuori il prete. Giunti nei pressi della canonica il Diavolo avrebbe ordinato al Negus (Antonio Prodi): “Fermati qui e se senti qualche rumore s’céflà (fischia)”. Finita la sortita il Prodi avrebbe chiesto conto al sindaco di quei due colpi di pistola che sibilando avevano squarciato il silenzio della notte. E di rimando il Diavolo avrebbe risposto a muso duro: “Tu non preoccuparti. Lo saprai domani. Vai a casa e stai zitto, altrimenti farò la pelle anche a te e ai tuoi familiari”.

Uno scatto dei funerali di don Umberto Pessina (1946)
Ma questa versione dei fatti non poteva funzionare. Non reggeva per un semplice motivo. Germano Nicolini al momento in cui don Umberto Pessina fu ucciso era a giocare alle bocce alle Tre Pecche.
Il capitano Vesce, però, non era certo il tipo da scoraggiarsi ai primi ostacoli. Interrogò di nuovo Antonio Prodi e questi al solito cambiò la sua versione. Insomma, Nicolini autore o mandante del delitto fa lo stesso.
Poco importa se poi al processo di Perugia Antenore Valla e Antonio Prodi sconfessarono ogni precedente racconto da loro stessi fornito. Sostenne in quella assise Antonio Prodi, detto Negus: “Ciò che è stato verbalizzato dai carabinieri non l’ho detto. I verbali li firmai molto dopo. Lo feci perché da giorni non avevo né mangiato né bevuto. E inoltre, perché venni picchiato”.
Il dibattimento in corso nel tribunale umbro proseguì impantanandosi in una serie infinita di contraddizioni con continui colpi di teatro, come quello dell’iniziativa di altri 2 ex partigiani: Ero Righi e Cesarino Catellani, che irruppero nel processo tramite una lettera, scritta prima di espatriare nell’ex Jugoslavia, nella quale si autoaccusarono della ronda e del delitto del prete. Ma quella nuova versione dei fatti, che pure presentava importanti novità, venne considerata dagli inquirenti poco veritiera.
Al termine dei lavori nell’aula giudiziaria Germano Nicolini fu condannato a 22 anni di galera, Ello Ferretti a 21, Antonio Prodi a 20. Tra condoni e amnistie il Diavolo uscì dal carcere solo nel 1957. E fu in quegli anni che per protestare la propria innocenza scrisse un tomo faticoso alla lettura, ma ricco di notizie, con tutta la sua storia giudiziaria: “Nessuno vuole la verità”, si intitola. E infatti nessuno la voleva sentire quella verità, men che meno il Pci, il partito del Diavolo che iniziò a bestemmiare per tutto il clamore che ancora si faceva attorno al nome di quel prete ucciso ormai tanti anni addietro. Fu così che il Partito decise di mettere una pietra tombale sulla vicenda di don Pessima, e con essa di seppellire anche le ragioni per le quali si batteva l’indomito Diavolo. Germano Nicolini, per parte sua, non rinnovò più la tessera comunista. E solo a micce bagnate si riappacificò con gli allora Ds.
La storia volle che il fatto sanguinoso del 1946 restasse avvolto da un assordante silenzio sino agli anni Novanta, quando l’ex partigiano e deputato comunista Otello Montanari lanciò il suo “Chi sa parli”, attivandosi per perorare la causa dell’innocenza di Nicolini.

Ed era tempo che a Correggio si vociferava di un terzo uomo che prese parte alla ronda con Ero Righi e Cesarino Catellani uccidendo don Umberto Pessina. In molti nel paese della Bassa erano a conoscenza di quella verità. Fino al punto che più d’uno si rieferiva al terzo uomo apostrofandolo come al masaprèt.
Inoltre in supporto al Diavolo si erano mossi anche i figli dell’ex comandante partigiano: Riccarda, per tanti anni dirigente del Pci e della cooperazione e poi assessore regionale alla Sanità (scomparsa nel 2007) e Fausto, dirigente e poi presidente dell’Asl reggiana. Al loro fianco Vincenzo Bertolini, ex segretario comunista di Reggio Emilia e per 20 anni compagno di Riccarda Nicolini.
Finalmente la verità venne a galla. Il misterioso terzo uomo, il ‘signor G’, che non era frutto di fantasie poliziesche o elucubrazioni di dietrologi, ma esisteva per davvero in carne e ossa, ebbe anche un volto e un nome: William Gaiti, al tempo muratore in pensione, ex partigiano torturato con un padre ammazzato dai fascisti, che nel settembre del 1991 si presentò alla porta dell’ufficio del procuratore della Repubblica di Reggio Emilia Elio Bevilacqua rompendo il muro del silenzio: “A don Pessina ho sparato io. Stavo con Catellani e Righi. Ero davanti alla canonica quando, non so perché, il prete mi è arrivato alle spalle. Forse stava rientrando e mi aveva visto. Mi ha dato uno spintone. Mi ha gettato contro il muro. La pistola è caduta, l’ho ripresa subito e mentre l’afferravo è partito un colpo. Il prete è andato a terra, colpito”.
Il maleficio è tolto. Il mistero dell’omicidio, dopo mezzo secolo, è risolto. Tre uomini la sera del 18 giugno del 1946 si erano recati alla canonica di San Martino Piccolo da don Umberto Pessina: Cesarino Catellani, Ero Righi, e William Gaiti. Quest’ultimo uccise il prete.
Rimaneva però una domanda: chi aveva ordinato una ronda armata per sorvegliare un parrcoco di campagna?
Trovata la risposta, si può davvero dire che la verità in questo caso superò la più fervida delle immaginazioni. La ricostruzione degli atti primitivi che generarono la vicenda comparve in un articolo firmato dal direttore della Gazzetta di Reggio dell’epoca, Umberto Bonafini, il quale spiegò come Antonio Rangoni da Correggio, archivista del Pci, portò al procuratore della Repubblica un nastro sul quale era incisa un’intervista ad Aldo Magnani, un apprezzato dirigente comunista, tra l’altro presidente del Cln. In quella registrazione alla domanda di Rangoni: “E per il delitto don Pessina come andarono le cose?”, Aldo Magnani fornì questa risposta: “Venne da me Morgotti (Ottavio Morgotti, dirigente del Pci di Correggio) per informarmi che la parrocchia di San Martino Piccolo costituiva un centro per un traffico d’armi pilotato dal parroco, il quale sarebbe stato in contatto con elementi fascisti. Ho detto a Morgotti di costituire una ronda e qualora i fatti supposti risultassero veri, di avvertire i carabinieri. Alcuni giorni dopo, un mattino, Morgotti venne da me in federazione per dirmi che la notte prima si era verificato l’episodio tragico della morte di don Pessina, avvenuta dopo una colluttazione. Decisi di parlare immediatamente col segretario Arrigo Nizzoli, il quale appreso che a sparare era stato William Gaiti, si oppose a qualsiasi denuncia ai carabinieri”.
Se i fatti si svolsero proprio a quel modo, nel 1946 sarebbe bastata una sola parola per scagionare da ogni accusa Germano Nicolini (che peraltro era amico di Aldo Magnani). Il Diavolo, apprendendo di questo altro doloroso risvolto della sua travagliata vita, ebbe a commentare: “Sono sconvolto… Non capisco questa ragione di partito che ha rovinato la vita a 3 innocenti. Cos’altro mai si può aggiungere?”.
Povero prete, povero Diavolo.

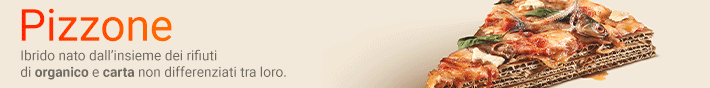





ALCIDE DE GASPERI HA SALVATO L’ ITALIA FACENDO APPENDERE MANIFESTI CON SCRITTO: NELL’URNA DIO TI VEDE STALIN NO
QUELLO STESSO DIO DECIDERA’ DI GERMANO NICOLINI , come di ognuno di noi.
L’Onnisciente è amore e misericordia, ma anche giustizia, verità e sapienza.
Quando , il più tardi possibile passeremo a miglior vita, anche noi vedremo tutto.
Nel frattempo SAN MICHELE ARCANGELO veglia su di noi.