Come ogni anno assisteremo, il 3 dicembre, a svariate iniziative che ruotano attorno al tema di disabilità perché in quella data è stata istituita la giornata internazionale delle persone con disabilità. Ci saranno flash mob, lumini accesi, feste e manifestazioni. E il disability pride.
Disability pride.
Tutti buoni, eh, gli intenti (un po’ meno le modalità).
Non nascondersi, in primis. Mi sembra un traguardo non da poco poiché pian piano negli ultimi anni stiamo assistendo a un’evoluzione rassicurante: nelle nostre città si vedono molte più persone con disabilità che escono di casa e cercano di condurre una vita pressoché normale senza aver paura del giudizio degli altri. Naturalmente ho precisato che “cercano”, perché evidentemente non è ancora possibile vivere una vita fatta di scelte libere; alla fine si impara a produrre strategie utili per dribblare barriere e percorsi inagibili in modo da non farsi sopraffare dallo sconforto che porterebbe solo a rintanarsi nuovamente in casa.
Diritti sanitari, LEA, assistenza personale individualizzata, miglioramento del sistema di inserimento lavorativo con attenzione particolare al fatto che vengono assunte solo persone per ricoprire profili bassi, riconoscimento della figura del caregiver familiare, istituzione della figura dell’assistente alla sessualità. Questi sono solo alcuni dei temi che saranno portati a gran voce nelle piazze delle grandi città.
E dopo?
Mi spiego. Per ottenere queste cose bisogna lavorare nei piani alti, entrare nella scia della politica di Stato e Regioni, che è poi quella che ha la possibilità reale di costruire una buona rivoluzione dei diritti delle persone con disabilità, e, una volta raggiunti, la difficoltà nel produrre un cambiamento ha due facce: quella economica e quella culturale.
Sono da sempre stata una sostenitrice del fatto che la seconda prevalga sulla prima perché i soldi si investono in ciò che si crede sia meritevole di ottenerli. Purtroppo non siamo ancora socialmente pronti per riconoscere uguaglianza di diritti tra le persone e a essere messe da parte sono in primis le persone con disabilità perché molto spesso non hanno nemmeno i mezzi per poterli pretendere.
Diffido molto sull’utilità di persone terze che parlano di disabilità e organizzano eventi a tema, perché, nonostante i buoni intenti, sentir parlare chi non ha una disabilità sortisce un effetto poco inclusivo. Queste persone dovrebbero cedere il microfono. Dovrebbero scostarsi dalla scena.
È giunto il momento di alzare la mano e parlare in prima persona perché solo conoscendoci potranno scegliere di averne meno timore e incominceranno a vederci molto più simili a loro.
Abbiamo davanti agli occhi una nuova generazione che non ha paura di parlare di sé e di far conoscere la disabilità da vicino. I social, poi, sono un mezzo utilissimo in tal senso, perché permettono di mostrarsi al mondo anche quando c’è notevole difficoltà a uscire di casa (non a causa della disabilità, naturalmente, ma a causa della mancanza di servizi e accessibilità). Siamo di fronte a un cambiamento che potrebbe portare anche a una rivoluzione culturale in tal senso. Se sono le persone con disabilità in primis a non aver paura di parlare di se stesse, a mostrarsi, a raccontarsi, a descriversi, dimostrando che non c’è nessuno di speciale, che la diversità esiste e si accetta, che gli ostacoli sono presenti e non ci sono eroi in grado di superarli. Parlare della disabilità in prima persona, quella vera, quella quotidiana, è l’unico modo utile per far sì che ci siano sempre più persone che si avvicineranno con meno timore e forse, finalmente, si potrà aprire una breccia nel muro culturale.

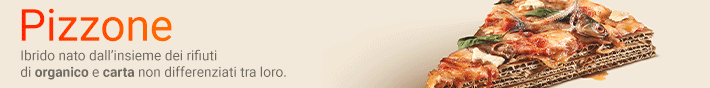




Ultimi commenti
Anche l' Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia .
Amara e splendida analisi che dovrebbe arrivare alle alte sfere!
Diranno, sia a sinistra che a destra, che c'è un disinteresse della politica, in particolare dei giovani, diranno che molti non votano perché pensano che, […]